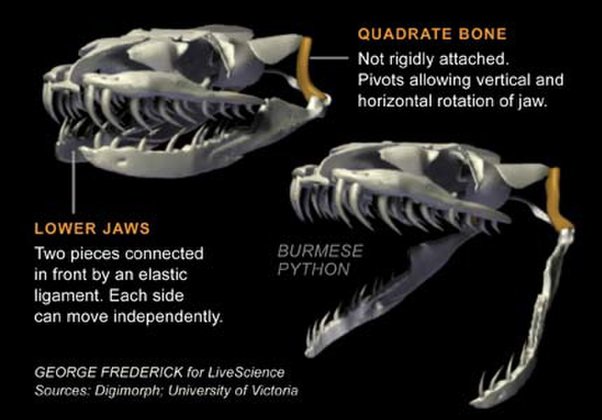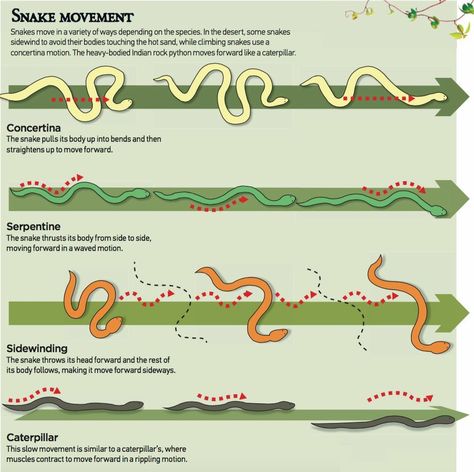Molto probabilmente stiamo vivendo nell'epoca più bigotta e perbenista di sempre.
Ci manca solo di sentire ogni mattina l'acre odore di carne bruciata degli autodafé invadere le strade, il fumo grigio dei roghi di film e libri proibiti, quelli che non rispettano le quote rosa e quelle nere.
Ogni santissimo giorno ci viene ribadito che esistono minoranze da proteggere, diversi da includere, un sesso debole a cui riconoscere inalienabili diritti.
Ci mancherebbe.
Lo sappiamo, lo abbiamo sempre saputo.
Però dirlo, scriverlo, magari urlarlo, non basta.
Bisognerebbe piuttosto non aver più bisogno di farlo.
Almeno smetterla di essere degli ipocriti.
Da un po' di tempo è cominciata un'assurda e inutile guerra tra i sessi.
Una cosa è evitare sfruttamenti e discriminazioni, un'altra gareggiare su chi ce l'ha più lungo o su chi è il più intelligente.
Andando avanti così si ribalteranno i ruoli e saremo noi maschietti il sesso debole.
Serve a qualcosa?
Mi sembra invece più giusto ribadire le nostre differenze, che ci sono.
"Voglio una donna con la gonna!", cantava quel maschilista di Roberto Vecchioni.
Poi aggiungeva, più o meno: "Almeno non stronza come un uomo!"
C'è una famosissima foto in bianco e nero di Moira Orfei di spalle (in evidenza il suo famoso fondo schiena) che passeggia fiera e tranquilla in mezzo a un manipolo di uomini che la guardano attentamente, non certo per ammirarne il taglio del vestito ("Gli italiani si voltano" di Mario de Biasi, 1954).
Oggi creare un'immagine del genere sarebbe impossibile.
Cos'era poi?
L'inevitabile, anche banale, constatazione dell'atavico rapporto tra i sessi: chi ammira e chi si fa ammirare.
Nulla di strano.
Paolo Bonolis, che non è uno stupido, ci ha costruito sopra il proprio successo televisivo.
Disdicevole magari dare una pacca sul sedere a Sofia Loren (o tentare di farlo) ma anche questo, nei film, si faceva.
Negli anni ottanta, l'Edwige ha edificato un impero sulla mania igienista che la portava, almeno due volte per ogni film come da contratto, a farsi una bella doccia rinfrescante.
Noi e Alvaro Vitali, anche in questo caso, guardavamo e tacevamo, ammirati.
Bello? Brutto?
Il giudizio estetico è sospeso.
Oggi comunque non c'è più nulla del genere in circolazione.
Meglio? Peggio?
Sta di fatto che nel frattempo l'uomo non è cambiato e la donna nemmeno.
"The monster society of evil" è una lunga storia di Capitan Marvel scritta e disegnata da Otto Binder e C.C. Beck per la Fawcett Comics e pubblicata dal 1943 al 1945 su "Capitan Marvel Adventures" dal numero 22 al numero 46.
L'eroe, che successivamente cambiò nome in Shazam per non confondersi con l'omonimo marvelliano e che venne poi portato in tribunale da Superman con l'accusa di plagio (forse per invidia, dato che vendeva molto più di lui) combatteva con i suoi supernemici coalizzati (era la prima volta che succedeva in un fumetto supereroistico): Mister Mind il verme senziente, il dottor Sivana e molti altri.
Credo sia l'unica storia così importante del periodo a non essere mai stata ristampata.
La D.C. ha sempre giustificato questa scelta per il fatto che al suo interno ci sarebbero imbarazzanti immagini e situazioni da censurare.
Cosa c'è di così grave, chiederete voi?
Presto detto: giapponesi dai denti aguzzi, un personaggio nero (che è spesso presente come contraltare comico nelle storie di Shazam) Steamboat, raffigurato con labbroni e classica parlata da schiavo del sud. L'epoca era quella; piena di inevitabili stereotipate raffigurazioni.
Nemmeno Will Eisner a quel tempo riusciva ad evitarle: Ebony, il compagno di Spirit, è esattamente così.
Nulla di così scandaloso e non pienamente comprensibile.
Eppure...
Io posseggo una copia dell'unica versione che ha circolato in tiratura limitatissima e mi è costata un botto.
Magari è stata solo un'astuta mossa commerciale...
Nick Fury, il supermarine bianco fino al midollo con la benda sull'occhio divenuto nel tempo direttore dello S.H.I.E.L.D., si è recentemente fatto schiarire la pelle, un po' come ha fatto Michael Jackson.
Mark Millar aveva introdotto questa nuova versione nel mondo Marvel alternativo degli Ultimates; Josh Whedon lo ha sdoganato come nuovo Fury nel film "The Avengers" del 2012.
Visto il successo planetario della pellicola, il fumetto, come spesso succede, ha pedissequamente seguito questa nuova strada.
Per amor di una intrinseca quanto inutile logica, il Nick nero (Junior) si scoprirà essere il figlio di quello bianco.
Stessa cosa, con molta meno logica e spiegazioni, è accaduta al guardiano del Ponte Arcobaleno di Asgard, Heimdall che nel film "Thor" del 2011, e di seguito per sempre, è diventato di colore. Fine pagliacciate.
Comunque nel democratico mondo dei fumetti americani i supereroi neri sono numericamente perfettamente bilanciati con quelli bianchi.
Esiste addirittura un Superman nero (il Presidente) di un mondo alternativo, ma va bene così.
La situazione dei neri in America è un eclatante esempio d'ipocrisia.
Li hanno deportati, schiavizzati e massacrati.
Un esempio fra i tanti: il 31 maggio e il 1 giugno 1921 a Tulsa, dopo uno scontro tra bianchi e neri davanti alla prigione dove era detenuto un giovane di colore accusato di aver violentato una ragazza bianca, una folla inferocita sciamò per le strade del quartiere afroamericano della città sparando e uccidendo chiunque trovasse sul proprio cammino.
Ad un certo punto persino un aereo sorvolò le strade mitragliando i neri che tentavano di mettersi in salvo.
Il risultato fu di almeno quaranta morti accertati, molto probabilmente più di trecento reali.
Il tragico evento è stato narrato in due serial: "Watchmen" (2019) e "Lovecraft Country" (2020).
Uno dei produttori di quest'ultimo, Jordan Peele, è, come Spike Lee, attivista convinto dei diritti dei neri.
In "Get out!"(2017) e "Us" (2019), utilizza l'affilata arma del grottesco per denunciare e sottolineare la loro condizione di perenni vittime e cavie di una società che nel tempo non ha per nulla cambiato atteggiamento nei loro confronti.
Non potendo evitare di riconoscere ai neri indubbie qualità artistiche (anche rischiando di scivolare verso triti stereotipi come l'ammettere che hanno la musica nel sangue), all'inizio li aveva trasformati in fenomeni da circo mascherati per l'occasione.
Al Jolson (Asa Joelson) era un bianco, per la precisione un russo americanizzato.
Fu il primo a vendere dieci milioni di dischi, il protagonista del primo film sonoro della storia: "The jazz singer"(1927).
Si esibiva a teatro con il volto e le mani dipinte di nero, sfruttando il morboso interesse del pubblico per l'esotismo, senza però nemmeno tentare di risolverne l'eterofobia.
Era lo stile chiamato blackface.
La gente rideva e si divertiva, ben sapendo che dietro quel ridicolo trucco c'era un bianco come loro.
In qualche modo questo li asssolveva.
Jolson non fu comunque il primo.
Intorno al 1830, l'attore Thomas Rice interpretava spesso sulla scena il comico ruolo del buffo e ridicolo schiavo Jim Crow, con le sue movenze esagerate e la parlata stereotipata.
Oggi in Canada e in America la pratica di dipingersi di nero per travestirsi e imitare le persone di colore è considerata razzista, allora era arte.
Sono entrambe distorsioni figlie del proprio tempo. Dipende solo dalle intenzioni.
Per fortuna gli americani, almeno nei film, si sono spesso ricordati, magari di malavoglia, di essere una società multirazziale.
Sidney Poitier è stato il primo attore di colore a vincere un Oscar.
Epocali e decisamente innovativi sono almeno due dei suoi film: "In the heat of the night" e "Guess who's coming to dinner", entrambi del 1967.
Il problema del razzismo e della xenofobia era ormai sul tavolo, difficile far finta di niente.
La cosiddetta blaxploitation, nei primi anni settanta, fu un genere di pellicole nelle quali gli afroamericani erano gli attori, spesso i registi, sempre il pubblico di riferimento.
Zeppi di stereotipi afro (in "Superfly" del 1972, Gordon Parks jr. interpreta il classico gangster nero dai vestiti sgargianti e catene d'oro al collo), ebbero comunque grande successo e furono anche un modo per ribadire al mondo la propria esistenza.
Pam Grier ne è stata una delle attrici più famose ("Foxy Brown", 1974), in seguito omaggiata nel 1997 da Quentin Tarantino in "Jackie Brown".
Spesso si divertivano a reinterpretare anche ironicamente classici del cinema come in "Blacula" (1972) e "Blackenstein" (1973).
La Coalition against blaxploitation ne criticava fortemente i contenuti considerati degradanti per i neri stessi, ma anche per il fatto che molti di quei film, nonostante fossero scritti e recitati da loro, avevano registi bianchi.
Nel 1975 riuscì a decretarne la fine.
Per un certo periodo l'America si è accontentata di sfornare ogni tanto nei film d'azione coppie nero/bianco o nero/giallo come
"Deadly weapon" del 1987 con Mel Gibson e Danny Glover oppure "Rush hours" del 1988, con Jackie Chan e Chris Tucker. Anche questo era un modo per espiare i propri peccati.
Ma recentemente sta facendo di peggio.
Si chiama blackwashing, ed è la moda di far interpretare da attori neri parti che da sempre, per logica o per abitudine, sono ad appannaggio dei bianchi.
Si contrappone al whitewashing che decenni addietro faceva l'esatto contrario.
Può avere una sua logica, sempre che rimanga coerente, che sia giustificabile e che non si esageri.
Ancor oggi, nonostante la situazione sia nettamente migliorata, solo l'11% circa dei protagonisti principali dei film in circolazione sono attori di colore.
Ovviamente esistono produzioni black oriented come "The underground railroad" del 2021, splendido serial tratto dal romanzo del premio Pulitzer Colson Whitehead ma che spesso hanno come specifico obiettivo proprio quello di trattare argomenti, storici o meno, sulla discriminazione razziale e sullo schiavismo.
Se però la presenza dell'attore nero risalta anomala come un chiodo nel muro senza nessun quadro appeso a giustificarlo, allora è ovvio e auspicabile che il pubblico s'infervori.
La serie Netflix su Resident evil, che oltretutto pare essere molto brutta, ne è un esempio eclatante: Lance Reddick, per me indimenticato protagonista di "Fringe", nero che di più non si può, è stato chiamato per interpretare il ruolo di Albert Wesker, il cattivo dei videogiochi, dalle chiare ed inequivocabili connotazioni ariane.
Per fortuna i fan sono intervenuti e la serie è stata cancellata dopo una sola stagione.
Sta per uscire il Pinocchio di Robert Zemeckis e si scopre che la Fata Turchina ha cambiato colore.
Senza nulla togliere in termini di recitazione a Cinthia Erivo, mi chiedo solo il perché.
Stessa domanda per il James Gordon di colore interpretato da Jeffrey Wright in "The Batman" del 2022, per la Ariel di Halle Bailey nel live action de "The mermaid" del 2023, l'Achille di David Gyasi in "Troy-fall of a city" serial del 2018 o infine per Corlys Velaryon interpretato da Steve Toussaint in "House of dragons" del 2022.
Nessuno mi darà mai ufficialmente una risposta sincera.
C'è chi arriva ad auspicare che ogni film rispecchi pienamente la società americana multirazziale esibendone ogni suo rappresentante.
L'Academy ha ufficialmente comunicato
che dal 2024 qualunque film ambisca all'Oscar dovrà rispettare
alcuni, semplici standard.
Ad esempio: almeno uno degli attori
protagonisti dovrà appartenere ad una minoranza etnica; almeno il
30% del cast dovrà essere rappresentato da donne, gruppi etnici o
razziali di minoranza, disabili, LGBTQ.
Da questo punto di vista "The
eternals" del 2021 è il film perfetto: nel gruppo ci sono un
nero (gay), una cinese, un indiano, una ispanica, un bianco, un
sudcoreano.
Manca il disabile, ma la prossima volta
faranno sicuramente di meglio.
E se invece, banalmente, gli attori
venissero scelti solo in base alle loro abilità recitative?
Un mondo semplice, più logico e, soprattutto, meno ipocrita.
Dopo la tragica e assurda morte di George Floyd, in America, così come in Francia e in Gran Bretagna, è scoppiata la furia iconoclasta degli afroamericani che li ha portati a distruggere e sfregiare le statue di comandanti, soldati e presidenti dell'esercito confederato.
Può anche essere comprensibile e giustificabile; lo è molto meno la scelta di alcuni stati di abolire il Columbus day sostituendolo con un più asettico e innocuo omaggio a figure religiose superpartes come, in Colorado, Madre Cabrini, la prima santa americana.
Sembra che nemmeno l'aver avuto un presidente nero sia servito per pareggiare i conti e passare finalmente oltre.
La cultura (e paura) dell'esistenza di un nemico, che negli Stati Uniti spinge buona parte della popolazione ad armarsi e della polizia a reagire alla minima provocazione con mezzi sproporzionati rispetto al reale pericolo, trova ancora nel nero o nell'ispanico il soggetto ideale.
Questo andrebbe sradicato, e non basta la censura o l'utilizzo di squallidi espedienti a fare ammenda dei propri peccati, soprattutto se si continua a commetterli.
A pensarci bene non è questione di bigottismo o perbenismo, ma solo di stupidità.



























.jpeg)